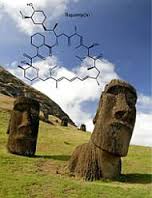La notizia arriva direttamente dai ricercatori della Columbia University
Medical Center (CUMC): bambini e adolescenti autistici avrebbero un
maggior numero di sinapsi.
Se avere un buon numero di sinapsi può essere un fattore positivo, averle in eccesso può essere deleterio. Come è possibile, dunque, che se ne formino addirittura in abbondanza?
Secondo
gli scienziati si tratta di una sorta di mancata “potatura”. Avete
presente cosa accade alla vegetazione se non viene mai potata nei mesi
primaverili? Ecco, nelle sinapsi avviene una cosa simile: si forma una
sorta di foresta cerebrale.
Il
rallentamento del processo cerebrale di potatura durante lo sviluppo
porterebbe a effetti profondi sulle funzioni del nostro cervello. Questo
perché, come ben si sa, le sinapsi sono i punti in cui i neuroni si
connettono e comunicano tra di loro. Va da sé che la comunicazione non può essere efficiente se è eccesiva.«È
la prima volta che qualcuno ha cercato e visto la mancanza di potatura
durante lo sviluppo dei bambini con autismo, anche se i numeri più bassi
di sinapsi in alcune aree del cervello sono stati rilevati nei cervelli
di pazienti anziani e nei topi con comportamenti autistico-simili»,
spiega il ricercatore professor David Sulzer
La potatura sinaptica sembra essere guidata da un processo di
degradazione cellulare noto come autofagia. L’unico modo per risolvere
il problema sarebbe l’ausilio di un farmaco che sia in grado di
ripristinare la normale potatura sinaptica.
Per tentare una possibile
soluzione è stata testata la rapamicina – detta anche Sirolimus. Si
tratta di un farmaco immunosoppressore tradizionalmente utilizzato nei
trapianti d’organi per evitarne il rigetto.
La ricerca, condotta per
ora solo su animali (modelli murini con autismo) è stata in grado di
tracciare il difetto di potatura di una proteina denominata mTOR – o
bersaglio della rapamicina nei mammiferi – che, tra le altre cose regola
la crescita e la sopravvivenza cellulare.
Quando
mTOR diviene iperattiva le cellule cerebrali perdono la capacità di
autofagia cellulare portando a numero eccessivo di sinapsi.Ripristinando
nei topi il normale processo di auofagia e la conseguente potatura
sinaptica i comportamenti autistico-simili sono diventati reversibili.
Per far tutto ciò i ricercatori hanno scelto di utilizzare la
rapamicina, la cui funzione – è risaputo – inibisce le proteine mTOR.
Il
farmaco funzionava comunque anche se somministrato dopo che i
comportamenti autistici si erano instaurati da tempo. Questo porta gli
scienziati a pensare che il medicinale può essere adoperato anche a
malattia avviata.
Secondo quanto riportato sulla rivista Neuron, nel cervello dei malati di autismo vi è una quantità eccessiva di proteina mTOR. La Rapamicina, tuttavia, è stata in grado di inibire mTOR riportando l’autofagia a condizioni normali.
«Il
fatto che possiamo ravvisare cambiamenti nel comportamento suggerisce
che l’autismo può essere ancora curabile dopo che è stato diagnosticato
al bambino, se riusciamo a trovare un farmaco migliore», dichiara il
prof. Sulzer.
«La cosa incredibile circa i risultati – continua
Sulzer – è che centinaia di geni sono stati collegati all’autismo, ma
quasi tutti i nostri soggetti umani avevano mTOR iperattiva e una
diminuzione di autofagia e tutti sembrano avere una mancanza di normale
potatura sinaptica. Questo ci dice che molti dei geni, forse la maggioranza, possono convergere sulla via mTOR/autofagia,
allo stesso modo in cui molti affluenti portano al fiume Mississippi.
Quando mTOR è instabile e ha ridotto l’autofagia, blocca la normale
potatura sinaptica che può essere alla base dell’apprendimento di un
comportamento appropriato che può essere una caratteristica unificante
di autismo».
Secondo Alan Packer, ricercatore americano della
Simons Foundation e co-finanziatore dello studio, eseguire uno screening
della proteina mTOR e l’attività autofagica potrà fornire in un
prossimo futuro un valido mezzo per diagnosticare alcune caratteristiche dell’autismo al fine di poter somministrare il trattamento più idoneo al soggetto autistico.
«Questa
interessante ricerca potrebbe aiutare a sviluppare la nostra
comprensione delle complesse differenze cerebrali che esistono tra le
persone con autismo e quelli che non hanno tale condizione. Tuttavia,
l’idea che un farmaco potrebbe essere sviluppato per trattare l’autismo
deve essere valutata con cautela. Oltre a considerare le implicazioni
etiche, ci chiediamo se è possibile estrapolare gli effetti dei farmaci
sui topi che mostrano un comportamento apparentemente autistico e simile
a esseri umani che in realtà hanno una reale disabilità», conclude
Carol Povey, direttore del Centro per l’Autismo della National Autistic Society.
Lo studio è pubblicato sulla rivista Neuron.
tratto da: stampa.it
 Quante
volte i genitori mi chiedono: «Prof, perché non li obbliga a leggere?»
oppure vengo interpellata in questo modo: «Prof, io compro libri su
libri ma mio figlio non vuole leggere. Che devo fare?» .
Quante
volte i genitori mi chiedono: «Prof, perché non li obbliga a leggere?»
oppure vengo interpellata in questo modo: «Prof, io compro libri su
libri ma mio figlio non vuole leggere. Che devo fare?» .

 Il
team di ricerca del Dr. Tang e di Sulzer ha trovato una spiegazione
a questa connettività atipica nelle sinapsi, i collegamenti fisici
attraverso le quali le cellule del cervello comunicano tra loro.
Un’interessante caratteristica dello sviluppo del cervello è che il
numero di sinapsi diminuisce con l’aumentare dell’età. I bambini più
piccoli hanno più sinapsi rispetto a ragazzi e adolescenti e le sinapsi
“extra” sono destinate a perdersi con il passare degli anni.
Il
team di ricerca del Dr. Tang e di Sulzer ha trovato una spiegazione
a questa connettività atipica nelle sinapsi, i collegamenti fisici
attraverso le quali le cellule del cervello comunicano tra loro.
Un’interessante caratteristica dello sviluppo del cervello è che il
numero di sinapsi diminuisce con l’aumentare dell’età. I bambini più
piccoli hanno più sinapsi rispetto a ragazzi e adolescenti e le sinapsi
“extra” sono destinate a perdersi con il passare degli anni.